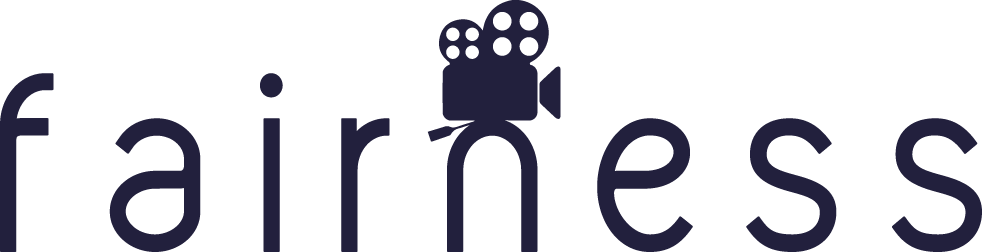Diffamazione a mezzo social, come difendersi dagli haters
 È elevatissimo il rischio di cadere, utilizzando i social network, nel reato di diffamazione. Reato tipico del mondo della stampa, che ha fatto vittime illustri nel corso dei decenni, e che da alcuni anni naturalmente si è trasferito anche nel mondo digital, con delle carenze normative che il passare degli anni ha colmato solo parzialmente.
È elevatissimo il rischio di cadere, utilizzando i social network, nel reato di diffamazione. Reato tipico del mondo della stampa, che ha fatto vittime illustri nel corso dei decenni, e che da alcuni anni naturalmente si è trasferito anche nel mondo digital, con delle carenze normative che il passare degli anni ha colmato solo parzialmente.
Si può incappare nella diffamazione a mezzo social con un post, privato o di una pagina, ma anche con un commento e, pensate, si può partecipare al reato perfino con un lillipuziano like (ad un commento). Parliamo di social come Facebook, ma anche di tutti gli altri, fino ad arrivare ai sistemi di messaggistica istantanea che non si salvano dal processo. Rientra tutto, infatti, nelle ipotesi previste dall’articolo 595 del codice penale, terzo comma («qualsiasi forma di pubblicità»). Insomma, oggi bisogna fare i conti con il diritto riconosciuto a tutti di esprimere il proprio pensiero, ma anche con i gravi rischi che ne conseguono, nel rispetto di valori come reputazione, dignità, e onore.
La dottrina a riguardo è in corso di aggiornamento, costante. Ma si può dire che il web viene equiparato, grossomodo, alla stampa. Quindi diffamare con un post equivale più o meno a diffamare con un articolo di un quotidiano. Sui social esistono strumenti “inibitori” per rimediare a un contenuto inadatto: ban, segnalazioni, blocchi. Ma spesso l’arma migliore per far giustizia è: lo screen. Archiviare immediatamente i contenuti, così da poterli conservare e consegnarlo agli atti. Ma di questo parleremo dopo. In ogni caso, delegare agli specialisti è la soluzione ideale per risolvere una controversia.
La vastità di materia e la difficoltà dei giuristi di venirne a capo, con la lentezza burocratica nota a tutti, rende il procedimento più complesso. Ma chi viene diffamato deve sentirsi sereno: la giustizia opera anche in materia social. Cosa accade, dunque, quando si commette diffamazione a mezzo social?
Il fatto che si tratti di un reato ormai ricorrente, ha reso la pena – in passato legata alla reclusione in carcere, nei casi più gravi – quasi esclusivamente di natura pecuniaria. Il tutto si risolve quindi con risarcimenti relativi al danno provocato. La persona che si sente diffamata, può prendere iniziativa avanzando una querela, con cui chiede al giudice di punire l’accusato stabilendo una pena congrua al valore della presunta diffamazione. Prima però, come accade per i giornali, può richiedere delle scuse pubbliche, per recuperare l’offesa. Questo deve avvenire in tempi ragionevolmente adeguati. Sui quotidiani, deve ad esempio avvenire il giorno dopo l’avvenuta ricezione della richiesta. Sui periodici, nel numero successivo, eccetera. Allo stesso modo l’avvocato che difende la parte offesa può pretendere un post, o qualcosa di analogo, per dimostrare il “pentimento”. E implicitamente questo prevede un invito a non farlo più, né a mezzo social né in altro modo. Se ciò non avviene, automaticamente si può proseguire con la querela.
Ecco, facciamo un esempio: Fairness – la nostra agency, che sicuramente conoscete già… – viene offesa da una sua concorrente, che pubblicamente dice al mondo del web: quelli della Fairness sono dei pagliacci! Cita il nostro account, o posta la nostra immagine, e una serie di persone leggono l’offesa, e magari la sostengono (perché siamo veramente dei pagliacci…!). Cosa può fare (oltre a fregarsene, chiaramente) la Fairness? Scrivere una lettera con il proprio avvocato, chiedendo di ritirare il post, o il commento presunto diffamatorio, ed esigere delle scuse pubblicamente da parte dei diretti interessati (ancor peggio se si tratta di competitor, che figuraccia!). Una via pacifica per chiudere la vicenda. Viceversa, si può denunciare, come detto in precedenza. Quindi, querelare.
Alcune note a margine che vi possono interessare.
- Ecco, come anticipato, persino chi ha commentato positivamente un post diffamatorio può essere perseguibile, qualora abbia reagito anche solo con un’interazione positiva (ve li immaginate i giudici che interpretano il sorrisetto che piange dalle risate, o lo stupito wow, o gli occhi a cuore?).
- Anche in una situazione come quella appena descritta in esempio, l’offesa generata è configurabile come diffamazione. Non si tratta di ingiuria. In questo senso infatti non basta l’ipotesi che l’offesa possa esser visibile anche agli offesi. Resta diffamazione. Perché si parli di ingiuria è necessario invece che gli offesi partecipino alla discussione, rispondendo. Tra l’altro l’esempio non è casuale: le questioni lavorative, assieme a quelle religiose e politiche, sono fra le tre principali cause di litigio a mezzo social.
- Due parole anche sulle prove. Come anticipato, diventano fondamentali gli screenshot: il fermo immagine dell’offesa, e tutto ciò che ruota attorno a essa. L’acquisizione, nella maniera più equilibrata possibile, delle parole incriminate. Troppo facile sarebbe infatti far sparire il post, eliminandolo.
- Ultima nota. Cosa può peggiorare il quantum risarcitorio? Chiaramente la portata della diffamazione. Il così detto rilancio. La componente, cioè, che può aumentare la viralità dell’offesa: condivisioni, re-post, retweet, ecc.
Capite, adesso, quanto rischiamo a fare i cret… ehm, volevamo dire, i leoni da tastiera?